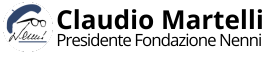Nel 1980, nel momento in cui il PSI sceglieva di tornare al governo dopo cinque convulsi anni, Bettino Craxi colse nella solennità del Parlamento. l’occasione per un discorso del tutto nuovo.
Un discorso di rottura dei tradizionali schemi diplomatici e delle consuete inclinazioni, convenienze e sudditanze della politica estera italiana; un discorso senza complessi nutrito di orgogliosa rivendicazione del ruolo internazionale del nostro paese. L’incipit non poteva essere più tranchant: “L’Italia ha avuto ed ha una politica estera? L’Italia è in condizioni per le sue risorse e la sua struttura di avere una politica estera di rilievo mondiale?
Al primo interrogativo risponderei con un giudizio severo.
Per troppo tempo c’è stata una timidezza quasi servile del paese verso i suoi più potenti alleati. In generale una scarsa coscienza dello Stato; e, se posso dirlo, forse anche una debole coscienza nazionale, una fragilità nei rapporti con i grandi gruppi di pressione che sovente hanno determinato, condizionato o rese obbligatorie vere e proprie scelte di politica estera.
Insomma, l’Italia che forse non può ambire a un ruolo mondiale, ma certamente a un ruolo interregionale, a cavallo di grandi regioni, ha avuto un’udienza limitata e forse una presenza che è al di sotto delle sue possibilità e dei suoi interessi.”
Nessun leader democratico e di governo aveva mai osato parlare di “timidezza servile” verso gli USA.
L’avevano fatto, sì, ma dall’opposizione, i revenants di un regime, quello fascista, asservito all’asse con la Germania nazista e sconfitto dalla storia. L’aveva fatto anche l’opposizione comunista, ma in nome di un servilismo verso la potenza sovietica decisamente più indigesto di quello filo americano.
La denuncia dell’anemia della nostra politica estera non era un’improvvisazione. Premessa di future affermazioni d’indipendenza quel discorso è il primo traguardo di una ricerca politica e culturale che durava da anni.
Per chi conosceva Craxi la politica internazionale faceva parte dell’identità in parte ritrovata in parte nuova dei socialisti italiani, ed era destinata a diventarne il carattere più originale e più importante. Soltanto un anno prima, su suo impulso, la Critica Sociale aveva riaperto il capitolo delle relazioni tra il socialismo e la nazione segnate da un tumultuoso alternarsi di sentimenti.
A Craxi, agli storici, ai giornalisti e ai politici socialisti e non socialisti che presero parte attiva all’iniziativa della Critica Sociale piacque battezzare quel nuovo corso come Socialismo Tricolore – un memore tributo a Cesare Battisti, patriota e martire socialista dell’irredentismo italiano nel Trentino ancora sotto dominio austriaco.
L’intento di Craxi era quello di sanare lo strappo tra socialismo e nazione apertosi alla vigilia della Prima Guerra mondiale. Per un momento la lacerazione fu ricucita nella solidarietà nazionale dopo Caporetto, ma si riacutizzò rovinosamente nel dopoguerra.
Fu allora che il PSI massimalista, abbagliato dall’illusione rivoluzionaria – “dobbiamo fare come in Russia” – sprezzante di fronte ai reduci, ai mutilati, dimenticò milioni di fanti proletari, i loro morti, le loro sofferenze in trincea. Con loro dimenticò anche i tanti socialisti combattenti mentre inneggiava a quel compagno Misiano rivoluzionario a Mosca e disertore in patria.
La guerra aveva provocato la rottura non solo tra l’internazionalismo pacifista e neutralista del PSI e l’interventismo democratico, ma anche quella del PSI massimalista con i socialisti europei schierati con i fronti patriottici dei loro paesi.
Quello, dunque, era lo scoglio, quello lo storico capo delle tempeste che doveva essere e che fu superato.
Non potendo appoggiarsi su Turati e Matteotti neutralisti coerenti Craxi evocava come riferimento l’interventismo democratico e di sinistra di altri socialisti riformisti come Bissolati, Salvemini, Bonomi, Rosselli, Lussu, di repubblicani come Piero Calamandrei, Ernesto Rossi, Pietro Nenni e del Mussolini ancora socialista.
Ma il dossier della Critica Sociale ispirato da un grande storico come Arduino Agnelli si spinse ben più lontano e ben più a fondo, sino a rintracciare le origini comuni dell’idea nazionale e della giustizia sociale nei primi patrioti italiani affascinati dalla grande Rivoluzione Francese. Siamo eguali perché nasciamo tutti enfants de la patrie, figli che insorgono a difesa della patria in pericolo nella Marsigliese di Rouget de l’Isle; fratelli in una patria che s’è desta contro gli oppressori stranieri nel più aulico inno di Goffredo Mameli.
Trent’anni prima che il genio di Cavour e le ambizioni sabaude lo portassero a compimento il Risorgimento è stato pensato e preparato dalla predicazione e dall’azione insurrezionale di Giuseppe Mazzini e, con lui, di una o due generazioni di giovani patrioti che fecero propri i suoi ideali e la sua lotta. Mazziniana nell’ispirazione se non nella tattica fu anche l’impresa italiana più grandiosa e decisiva di tutto il Risorgimento: la spedizione dei mille.
Le camice rosse di Garibaldi partite da Bergamo e da Milano, da Genova e dalla Toscana combatterono per unire il Sud al Nord d’Italia e vinsero grazie ai patrioti e al popolo meridionale insorti contro il proprio sovrano e in aiuto ai suoi liberatori. La guerra di conquista delle due Sicilie resta tra le imprese politico militari italiane la più importante, la più gloriosa e la più nota al mondo.
Il democratico Mazzini e il socialista Garibaldi erano uomini di sinistra e nessun’altra impresa della sinistra italiana è paragonabile a questa.
Nemmeno la Resistenza. E anche la Resistenza – almeno dalla maggioranza dei suoi protagonisti – fu combattuta per amore della patria, una patria sconfitta e umiliata dalla follia guerrafondaia e subalterna ai tedeschi di Mussolini e dei fascisti. Solo l’ignoranza, un’accecante faziosità o il più meschino calcolo politico possono ancora oggi insinuare l’estraneità dei socialisti alla nazione.
Quando Giorgia Meloni, come ha fatto di recente, farnetica annunciando “la sconfitta storica della sinistra che voleva sostituire il rosso al tricolore” calpesta la storia, la verità e l’evidenza: il rosso è uno dei colori della nostra bandiera e l’Italia è stata unita proprio grazie alle camice rosse – dalle loro baionette innestate – per non dire che solo un orbo o un cieco può negare il contributo della sinistra socialista e democratica – e di quella comunista – alla guerra partigiana e alla liberazione dal nazi-fascismo.
Tutto ciò non significa affatto che i socialisti siano stati, sempre e tutti, patrioti e nazionalisti, tantomeno che lo siano come lo sono le destre.
Un conto è il nazionalismo di chi lotta per liberare la propria patria dall’oppressione straniera tutt’altro conto il nazionalismo aggressivo, guerrafondaio, ostile per principio ai propri vicini e ad altre nazioni libere. Ancora diversi furono il nazionalismo tardo colonialista dei conservatori e quello imperialista del fascismo.
Un’altra importante conseguenza di quella stagione – conseguenza implicita nella riscoperta del combattentismo socialista, del genio di Garibaldi e delle capacità di comandanti come Carlo Pisacane, Carlo De Cristoforis, Carlo Bianco – fu l’approccio del tutto nuovo alla questione militare.
Craxi volle al Ministero della Difesa un socialista come Lelio Lagorio e, insieme, dedicarono alle tradizioni, ai mezzi e alla professionalità militari un’attenzione e una considerazione del tutto aliene dal pregiudiziale antimilitarismo del passato.
Motivati anche da quei precedenti storici Craxi e i socialisti s’impegnarono – e impegnarono i governi di cui facevano parte – a rafforzare i nostri apparati di difesa, la nostra deterrenza militare e i nostri servizi di intelligence.
Nella storia del mondo, quella antica e quella contemporanea, gli Stati sono tutti, più o meno, consapevoli che la politica estera, anche la più pacifica, la più prudente e ristretta agli scopi di sicurezza nazionale, non può essere efficace se non si dispone di una forza militare che possa essere dispiegata in caso di necessità. Non credo che questa regola sia in contraddizione con il dettato scolpito nella nostra Costituzione:
“L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”.
E, in effetti, la Costituzione non ha impedito le diverse missioni militari internazionali – con un velo di ipocrisia definite umanitarie o di pace – cui l’Italia ha partecipato anche quando non erano direttamente in gioco interessi nazionali, ma la solidarietà con popoli oppressi e i vincoli di trattati internazionali.
Oggi, cosa resta del risveglio e del fervore politico di quegli anni ottanta? Se dovessimo riproporre gli interrogativi allora sollevati da Craxi dovremmo concludere ancora più amaramente che no, l’Italia non ha una politica estera, non ha senso dello Stato e, sebbene abbia un sentimento nazionale ha scarsa coscienza dei nostri interessi e dei nostri doveri.
Né si può dire che sia superato il servilismo verso gli alleati: basti pensare alla partecipazione, nel 2011, dei nostri Tornado e delle nostre navi militari ai bombardamenti francesi, inglesi e americani sulla Libia di Gheddafi in spregio agli accordi appena stipulati e in totale contrasto con i nostri interessi. Conseguenza di quell’improvvido attacco sono stati nove anni di guerra civile libica. Il nostro ruolo si è ridotto all’impotenza di iniziative diplomatiche inconcludenti perché segnate dalle opposte strategie tra alleati – segnatamente tra Italia e Francia – e prive di ogni deterrenza militare.
E ora di fronte alle nostre coste meridionali, in una Libia sempre più divisa, assistiamo a un disastro storico: i mercenari di Putin si installano in Cirenaica e i mercenari di Erdogan in Tripolitania. Altro che mare nostrum e “quarta sponda” dell’Italia mediterranea! Dopo più di un secolo prima di italianità e poi di indipendenza la Libia torna nell’orbita delle ambizioni imperiali della Turchia ottomana e di quelle del nuovo zar russo.
È questo il bilancio dei sovranisti al mojito e all’amatriciana: strillano “prima gli italiani” e subito cedono il passo agli stranieri.
Non migliore prestazione hanno sin qui offerto Conte e Di Maio per due anni inerti di fronte alla crisi libica, pellegrini tra le capitali con l’aria di turisti in visita: meglio Trump o la via della seta, il Sultano o lo Zar? E con l’Egitto che si fa? Vendiamo le armi o facciamo la faccia feroce?
La politica, soprattutto la politica internazionale, è una cosa tremendamente seria e richiede preparazione, passione, costanza. Non è materia per dilettanti, improvvisatori, ciarlatani che proiettano su scala mondiale i soli talenti che possiedono: la boria degli ignoranti e il sussiego dei parvenus.
Al loro cospetto crescono l’ammirazione e il rimpianto non solo per De Gasperi, Nenni e Moro, per Craxi e Andreotti, ma anche per Berlusconi e Prodi.
Quando il presente non ha luce né riferimenti è naturale sperare come Simone Weil che “il passato ci salverà”. È vero, è giusto: il passato digerito e rielaborato insegna, illumina, ispira ma senza lotta non basta, senza lotta non c’è speranza.