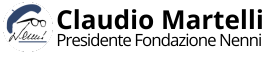“Repubblica!” titolava su nove colonne l’Avanti! del 5 giugno. L’interminabile scrutinio al cardiopalma era durato due giorni scanditi da contrastanti annunci. Infine, la sera del 4, la proclamazione. Dall’alba gli strilloni socialisti per le strade già affollate di Milano e di Roma sembravano esultare gridando “Repubblica”. In quel 1946 l’Avanti! con le sue 360.000 copie vendute era il primo giornale italiano. Il sottotitolo – ”Il sogno centenario degli italiani onesti e consapevoli è una luminosa realtà” volava davvero alto. Ma c’è n’era ben donde. La repubblica è stata l’unica rivoluzione incruenta e vittoriosa della storia d’Italia.
Sempre in prima pagina, a destra, spiccava quel “Grazie a Nenni” con cui tutta la redazione e Ignazio Silone – il grande scrittore direttore dell’Avanti! – spiegavano la verità politica di quella vittoria indicandone l’autore. Mai riconoscimento fu più meritato.
Senza l’impegno testardo e infaticabile del grande leader socialista davvero non si sa quale esito avrebbe avuto la battaglia. Nemmeno si può dire se, senza Nenni, battaglia ci sarebbe stata. Certo, la storia non si fa con i “se”. Ma senza i “se” la storia non si capisce. Senza i se non si può capire il labirinto di intenzioni e il conflitto di volontà da cui scaturì quella vittoria.
Alle generazioni successive, ancor più a noi, oggi, la scelta degli italiani di allora appare naturale, facile, pressoché scontata. Così non fu.
Alla fine gli italiani in maggioranza scelsero la repubblica chi per principio chi per disgusto di Vittorio Emanuele. Le responsabilità della corona erano pesantissime, inescusabili. Il re aveva aperto la strada al fascismo, consegnato il potere a Mussolini per ventun anni, approvato leggi liberticide, l’obbrobrio di quelle antisemite e lo sciagurato ingresso in guerra nel giugno del ’40. Per non dire della fuga a Brindisi mentre la patria stava morendo. Eppure, agli occhi di molti italiani, la monarchia conservava un’aura dell’antica sacralità e i Savoia apparivano garanti dell’unità nazionale e custodi dell’ordine costituito. I più indulgenti replicavano alle accuse osservando che quello stesso re il 25 luglio aveva infine fatto arrestare Mussolini. Per l’aristocrazia, per i possidenti, per l’esercito legato al giuramento di fedeltà il re era pur sempre il vertice dello Stato, l’arbitro tra i poteri, il dispensatore di privilegi e del prestigio della corona. Nelle classi più povere, specie del meridione, era radicato un sentimento di rispetto e di devozione. Dunque, agli occhi di quella che sembrava la maggioranza del popolo e soprattutto della classe dirigente (in primis la Fiat degli Agnelli) tanto bastava per perdonare il re e se non proprio quel re certamente la monarchia sabauda.
Il 9 maggio il Quirinale giocò l’ultima disperata carta: l’abdicazione di Vittorio Emanuele e la successione al trono del figlio Umberto già da due anni luogotenente del padre. L’illusione di salvare la dinastia durò meno di un mese, Umberto fu re, ma, come si era augurato l’Avanti!, “Re di Maggio”, re per un mese. Nondimeno, quando Umberto volò in esilio, anche l’Avanti! gli riconobbe rettitudine e dignità personale.
Nel corso della lunghissima campagna referendaria De Gasperi, ben conoscendo il sentimento degli elettori cattolici in maggioranza favorevoli alla monarchia mantenne sino all’ultimo un atteggiamento così equidistante da apparire equivoco e meritarsi dai socialisti l’appellativo di “signor ni”, cioè di un leader incerto tra il sì e il no, sospeso “in ipocriti agnosticismi mascherati di democrazia”. Lasciando piena libertà di coscienza la maggioranza della Direzione dc, alfine, si pronunciò per la repubblica.
Nenni aveva dovuto badare anche alla sua sinistra consapevole com’era che la subordinazione a Stalin poteva costringere Palmiro Togliatti a nuovi imprevedibili voltafaccia e compromessi come si era visto con la svolta di Salerno. Nel ’44, Togliatti aveva giustificato la fine della pregiudiziale anti monarchica con la necessità di allargare il fronte antifascista per vincere la guerra. Piccati, Nenni e l’Avanti! reagirono: “C’è qualcosa di più importante della guerra ed è il fine della guerra” e “il fine è quello di eliminare dalla direzione politica della Nazione le forze, gli interessi, gli uomini del 25 luglio e dell’8 settembre” che “sotto mutate spoglie sono ancora quelli della marcia su Roma e dell’entrata in guerra”. Ancora agli inizi del ’45 l’Avanti! ammonisce che non può essere accettata “la tesi che subordina la politica in tutti i paesi agli interessi della diplomazia sovietica”. Nenni è turbato dalla freddezza di Togliatti e solo alla fine di quel 1945 dopo un comizio socialcomunista annota nei suoi diari: ”Non v’è dubbio che l’odio della massa è oggi diretto contro il Quirinale. E questa è stata, in gran parte, opera mia. Anche Togliatti stamattina ha dovuto alfine pronunciare la parola repubblica”. Alfine pronunciare…
*
Lo stesso giorno, su un’altra scheda, si votò per eleggere su base proporzionale i 574 deputati dell’Assemblea Costituente. Il raffronto tra il voto referendario e il contemporanee voto proporzionale è illuminante. Per la Repubblica votò il 54,2 per cento. Nell’elezione per la Costituente socialisti, comunisti e laici repubblicani assommarono il 46 per cento. In apparenza, dunque, il 92 per cento dei voti repubblicani erano di sinistra e laici. Eppure, non sarebbero bastati a vincere senza il concorso di quell’ 8 per cento – due milioni di voti – che decisero la vittoria. Di chi erano quei voti? Elettori della DC che a differenza della grande maggioranza monarchica dei cattolici votarono repubblica? Superstiti di Salò che votando per la repubblica si vendicarono del “tradimento” del re al Duce? Impossibile dirlo.
I flussi elettorali allora come oggi si mossero in diverse direzioni. In alcune province del sud anche buona parte degli elettori di sinistra votò per la monarchia che trionfò a Roma e ancor più a Napoli. Dunque, il concorso di voti non di sinistra e non laici fu superiore ai due milioni. Infine, a decidere, potrebbero esser state le donne per la prima volta ammesse al voto. Era passato mezzo secolo dalle battaglie per il suffragio femminile di Anna Kuliscioff, la luminosa, fervente socialista russa innamorata dell’Italia che rimproverava al suo compagno Filippo Turati il tiepido impegno per la causa delle donne. Fatto sta che appena poterono votare le donne italiane votarono più numerose degli uomini.
Quel doppio voto – referendario e rappresentativo – battezzato dalla partecipazione del 90 per cento degli aventi diritto è l’atto fondatore insieme della repubblica e della democrazia italiane. La sovranità passa dal re al popolo e dal popolo ai suoi rappresentanti eletti cioè al Parlamento. Con la Repubblica gli italiani cessano di essere sudditi e diventano cittadini, lo Stato e i suoi funzionari applicano la legge e rispondono alla legge, la giustizia è amministrata in nome del popolo, i comuni, le provincie, le regioni godono di autonomia e responsabilità, i diritti civili e quelli sociali sono riconosciuti e tutelati, le relazioni internazionali corrispondono agli interessi del paese e sono amministrate dai governi e dai parlamenti senza interferenze della corona e condizionamenti dinastici.
Come spiega bene Giovanni Sabbatucci nel suo articolo nell’Avanti! di oggi, sulle speranze, sulle illusioni, sul sentimento unitario di quel 46 per cento di elettori socialisti, comunisti, repubblicani l’anno dopo, il 1947, calò la scure di una scelta storica ineludibile: la scelta tra mondo occidentale e mondo comunista. Salvo alcuni azionisti – Parri, Lombardi, De Martino – che scelsero il socialismo, gli altri azionisti e tutto il PRI scelsero l’alleanza occidentale e la DC. Nenni, sordo ai richiami dell’ala democratica e riformista e dei socialisti europei, scelse invece l’alleanza con il PCI, con Mosca, con Stalin.
Perché?
La giustificazione di Nenni fu di aver voluto garantire “l’unità della classe lavoratrice”. L’imperativo doveva essere davvero categorico per spingerlo non solo a preferire l’alleanza con il PCI, ma addirittura a fare liste comuni. Com’era prevedibile nella disfatta comune il PCI fece man bassa dei seggi mentre il PSI perse più di metà di quelli conquistati due anni prima, alla Costituente. Un disastro politico e un tracollo elettorale che nessun pregiudizio ideologico e nessuna vocazione classista può spiegare.
Il perché di quella scelta va cercato altrove. Dove? Nel PSI – in misura molto minore anche nel PCI – gruppi e correnti di militanti, negli anni della resistenza e della lotta partigiana, avevano cementata un’intesa ben più intensa di una semplice alleanza. Ancora negli anni sessanta e settanta nelle parole di vecchi compagni della sinistra socialista, tante volte ho sentito vibrare la corda dell’unità della classe come fondamento, bussola e scopo del loro agire. Nel PSI del ’46 la tendenza massimalista, filocomunista e fusionista era maggioritaria. Ancora una volta abbagliati dall’illusione di “fare come in Russia”, sorretti dal mito unitario della classe quei socialisti erano pronti a sacrificare su quell’altare il loro stesso partito.
Quel mito erroneo e potente travolse anche Pietro Nenni. Forse lo condivideva, forse ne aveva paura. Paura di sfidare il PCI e il dogma dell’unità della classe lavoratrice, paura di perdere il partito subendo una drammatica scissione a sinistra.
Giuseppe Saragat invece paura non ebbe. Sin dall’inizio vedendo arrivare la tempesta scelse la socialdemocrazia europea e l’occidente, mise in guardia il partito dall’ubriacatura massimalista e dalla subordinazione a Stalin poi, inascoltato, abbandonò il Congresso di Roma, riunì gli eredi del riformismo turatiano e la meglio gioventù socialista a Palazzo Barberini e fondò un nuovo partito. Da quel momento Giuseppe Saragat diventa l’alfiere di un riformismo minoritario e il rivale politico di Nenni che pure due anni prima l’aveva presentato agli altri dirigenti come “il migliore di tutti noi”.
*
1946/1948: dal trionfo della Repubblica al tracollo del Fronte popolare quel biennio segna in modo indelebile il secondo dopoguerra italiano. Bagliori di gloria e cadute nella polvere hanno continuato ad alternarsi anche nei successivi settant’anni, fino al crollo del ’92, fino allo smarrimento e alla diaspora degli ultimi decenni.
Il socialismo democratico in tutto il mondo conosce successi e sconfitte e non è mai morto. Non sono morti i suoi ideali e il suo robusto radicamento. Guida o partecipa ai governi di molte nazioni d’Europa, dell’Asia, del continente australe, rinasce persino negli USA innervando di fresche energie e di sete di giustizia uno stanco partito democratico.
In Italia è tempo di mettersi alle spalle il lungo inverno del nostro scontento, delle divisioni, dei risentimenti, delle modeste ambizioni all’ombra di protettori vuoi di destra vuoi di sinistra. La premessa di tutto è conquistare un pensiero autonomo, fondamento di ogni autonoma iniziativa. Lo stato del nostro paese è tale da esigere la mobilitazione di tutte le energie e di tutti i talenti di cui l’Italia dispone per realizzare la grande riforma delle istituzioni immaginata da Craxi. La rinascita socialista oggi più di sempre si identifica con il risorgimento repubblicano.