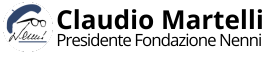Noi, italiani ed europei, combattenti sempre riluttanti non abbiamo titolo per ergerci a giudici severi degli errori americani. Non dimeno per rispetto della verità e per onorare i nostri morti abbiamo il dovere della lealtà e della verità.
Che cosa resterà di tutto quello fatto in Afghanistan dall’Europa, dalla NATO, dagli USA?
Il modo più difficile di combattere è quello di un esercito che volge le spalle al nemico. Il nemico attacca e colpisce con maggior facilità chi esita incerto se arretrare o difendersi. Così accade nelle ritirate ed è per questo che spesso risultano rovinose. Quel che sta accadendo in Afghanistan di fronte all’impetuosa avanzata dei talebani questa volta sostenuti anche dai capi tribù o signori della guerra, conferma una regola generale ben nota agli USA oltre che dall’esempio di altri imperi insabbiati e poi sconfitti in quelle terre anche dall’umiliante esperienza diretta della fuga da Saigon. Ma la fuga da Kabul presenta specificità e aggravanti che coinvolgono insieme con precise responsabilità politiche, diplomatiche e militari il sentimento stesso di una grande nazione sempre più riluttante a sopportare i costi umani e economici dell’occupazione militare di un paese lontanissimo e del sostegno a un regime tanto amico quanto inadeguato e corrotto.
Noi, italiani ed europei, detentori di un’ambigua potenza celata nell’ombra di sicurezza garantita dall’America, combattenti sempre riluttanti e a metà non abbiamo titolo per ergerci a giudici severi e censori degli errori americani, non dimeno per rispetto della verità e per onorare i nostri morti abbiamo insieme il dovere della lealtà e della verità. Tra accelerazioni e rinvii il ritiro dall’Afghanistan era diventato da tempo un mantra della politica estera americana, se non già da prima almeno dalle presidenze di Obama e di Trump. Dodici anni di irresolutezza tra impegno presente e disimpegno futuro, tra combattimenti e peace keeping, tra riforme civili e democratiche, imposizione di leadership aliene e prassi corruttive hanno fecondato il terreno propizio alla finale disfatta strategica. Nel frattempo gli USA avevano posto fine all’occupazione dell’Iraq, la seconda immotivata e disastrosa impresa di Bush utile solo a diluire e a distrarre dall’investimento strategico sulla prima, quella afghana appunto. Infine, Trump e poi Biden, trascorsi vent’anni di occupazione, hanno prima annunciato poi messo in atto il ritiro americano e delle truppe alleate. Trump l’aveva promesso ai suoi elettori programmandolo per il maggio scorso, Biden, l’ha solo posticipato all’11 settembre.
Probabilmente scopo della dilazione era quello di avere più tempo per organizzare il disimpegno e l’evacuazione in modo ordinato e per ottenere dai talebani al tavolo dei negoziati di Doha garanzie di una pacifica transizione di poteri – “neanche un morto americano!” era infatti il suo imperativo. Il calcolo si è rivelato drammaticamente sbagliato e l’annuncio, sia dai talebani sia e ancor più dagli afghani, dagli americani stessi e dagli uomini della coalizione è stato interpretato per quello che effettivamente era: una resa senza condizioni. Anche la scelta simbolica della data – la ricorrenza dell’11 settembre, i vent’anni dopo l’attacco alle torri gemelle e la strage di New York – doveva significare la fine della lunga belligeranza invece è diventata metafora e messaggio non di pace ma di sconfitta per gli USA e di vittoria per i talebani. Come una parentesi che si chiuda e cancelli vent’anni la resa è anche un ritorno allo status quo ante. La prima prevedibile conseguenza è stata il rapido disfacimento dell’esercito e del regime afghano con la fuga del presidente Ghani l’accademico banchiere scelto dagli americani. A suffragarla e mostrarla al mondo è subentrato il panico di centinaia di migliaia di afghani – donne soprattutto – illusi dall’occidente che un’altra vita era possibile e oggi abbandonati in balia della vendetta dei talebani persecutori di ogni devianza da un islam primitivo e brutale e dal loro personale arrogante potere.
E troppo presto per capire le conseguenze geopolitiche del disimpegno americano dall’Afghanistan. I due precedenti exit, dall’Iraq e dalla Siria, hanno aperto la strada alle ambizioni di Iran, Russia e Turchia a conferma di un’altra inossidabile regola delle relazioni internazionali che vuole che il vuoto lasciato da una grande potenza sia presto riempito da qualcun altro.
Intanto possiamo osservare che la Cina è stata la prima potenza a riconoscere la vittoria dei talebani identificati con lo stesso popolo afghano. Gli esperti ritengono che per assicurarsene il sostegno i talebani eviteranno scorrerie ideologiche nel confinante territorio cinese abitato dalla minoranza islamica degli uiguri le cui speranze autonomistiche sono sistematicamente represse da Pechino.
Imprevedibili le reazioni da parte dell’Iran con la sua lunga frontiera geografica e religiosa mentre appare scontata la solidarietà ai talebani dell’ambiguo Pakistan – il vero protettore di Osama Bin Laden – legato all’Afghanistan dalla comunanza etnica e religiosa della stirpe pashtun. Tutto all’opposto Russia e India non hanno nulla da festeggiare col rafforzamento di tradizionali nemici.
Quanto all’Italia e all’Europa la loro ventennale presenza militare in Afghanistan a fianco degli Stati Uniti si è caratterizzata per un approccio non da combattenti ma, sebbene armati, da portatori di pace anche quando non senza ambiguità i loro compiti erano quelli dell’addestramento militare. Al loro fianco centinaia di operatori di organizzazioni non governative si sono dedicati insieme a pubblici ufficiali a compiti civili quali la definizione insieme agli afghani di codici e procedure giuridiche, all’approntamento di strutture sanitarie, alle esigenze educative, famigliari e professionali delle donne afghane.
Oltre all’impegno morale e umanitario di organizzare corridoi umanitari per accogliere in Italia e in Europa i cittadini, ormai profughi, afghani che hanno lavorato con noi e che oggi sono esposti alle rappresaglie talebane c’è una domanda angosciosa che ci sovrasta. Che cosa resterà di tutto quello che hanno significato questi venti anni, dell’impegno, del lavoro, dei sacrifici fatti da tanti italiani, militari e civili e, più in generale, che cosa resterà di tutto quello fatto in Afghanistan dall’Europa, dalla NATO, dagli USA? Ho detto dei profughi da accogliere e non mi riferisco alla lezione politica da trarre da un’esperienza conclusa amaramente nella disfatta militare e nel caos civile. Penso alla possibilità per quanto remota e impraticabile oggi possa apparire di mantenere un contatto e una relazione con il popolo afgano, di non lasciare che vengano estirpati senza resistenza i semi di libertà, di democrazia, di tolleranza, di umanità che sono stati piantati.
Sono sicuro che tra i profughi questa sarà un’idea condivisa, e se sarà anche la nostra idea, se animerà una comune volontà di agire nelle forme e nei modi possibili per non lasciare inaridire i semi piantati allora qualcosa, forse il meglio, di questa esperienza e dei tanti sacrifici che è costata resterà né inutile né vana nelle loro e nelle nostre menti e nei loro e nei nostri cuori.