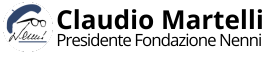Gli accadimenti di questa estate e le decisioni americane che li hanno innescati sono stati oggetto di una impressionante mole di giudizi critici. Per comodità possiamo distinguere le critiche a valle, cioè alle disastrose modalità del ritiro imputabili a uno sconcertante difetto di pianificazione politica, militare, diplomatica e di intelligence dalle critiche a monte cioè alla decisione madre, quella di ritirarsi in pochi mesi dall’Afghanistan dopo vent’anni di occupazione. Nella Newsletter di agosto ho discusso le prime, qui mi soffermo sulle seconde. Come sappiamo la decisione di lasciare Kabul fu assunta nel 2020 da Trump e confermata da Biden nel 2021 con l’accordo della NATO ma sorprendentemente senza invitare al tavolo del negoziato il governo legittimo dell’Afghanistan. Che gli USA volessero porre fine alla più lunga delle loro guerre era chiaro da molto tempo e Biden di fronte alle prime contestazioni alla caotica evacuazione ha puntigliosamente rivendicato di aver sostenuto il ritiro già quand’era vice di Obama. Nel remain di dieci anni fa pesò l’opinione dei militari, contarono i progressi nel Nation Building e a decidere Obama furono l’inopportunità di aggiungere una nuova ritirata a quella dall’Iraq, al mancato intervento in Siria e alla delusione per il rapido sfiorire delle primavere arabe.
L’errore di Biden
Nelle successive conferenze stampa Biden ci ha tenuto anche ad allontanare da sé ogni responsabilità rispetto al disegno di costruire in Afghanistan un nuovo stato – “al Nation Building – ha detto – non ho mai creduto” – ribadendo che l’unica motivazione della presenza delle truppe americane era quella di sradicare il terrorismo. La versione di Biden non è solo molto partigiana, il suo effetto retroattivo priva di motivazioni e di scopi costruttivi – l’interesse del popolo afghano – la ventennale occupazione. Delegittimata moralmente e idealmente la guerra più lunga diventa così preludio e giustificazione di una resa totale, senza che vi sia stata una sconfitta militare e alla sola condizione di poter scappare incolumi. Di conseguenza il paese non viene affidato a un governo di unità nazionale né il nuovo/regime monitorato da un qualche arbitrato internazionale ma riconsegnato ai talebani così accreditati come genuini rappresentanti dell’indipendenza nazionale e
della volontà del popolo afghano. Ma davvero come dice Biden il Nation Building oltre a non esser mai stato il vero scopo della guerra è stato un fallimento totale?
Equivoci e realtà del Nation Building
L’offensiva del 2001 degli USA e della NATO si abbatte su un paese distrutto dalla precedente invasione russa e, soprattutto, dalla successiva guerra civile e su una tragedia storica, originaria, quella di un popolo vittima, innanzitutto, della sua arretratezza, del fanatismo dei suoi despoti – signori della guerra e talebani – usi speculare sulla miseria dei suoi abitanti, sul fanatismo religioso come sulla massiccia coltivazione del papavero e sul traffico criminale di oppio e di stupefacenti. Nulla come la condizione di schiavitù e di apartheid in cui erano tenute le donne afghane misura l’abisso di questa arretratezza e la cifra morale della setta talebana che appena tornata al potere già prenota e si disputa la proprietà delle ragazze e delle donne da violentare subito alle altre promettendo il ritorno alla sottomissione della sharia.
Invece in questi venti anni la schiavitù femminile e, più in generale, le pietose condizioni umane degli afghani avevano finalmente conosciuto tregua e ristoro. Piaccia o non piaccia ai cultori reazionari di tutte le arretratezze e di tutte le infamie purché autoctone e incontaminate dalle perversioni occidentali, i vent’anni di occupazione USA e NATO e gli aiuti profusi in tutti i campi da molti governi e da molte organizzazioni non governative avevano fatto registrare tra il 2001 e il 2021 i maggiori progressi nella storia moderna dell’Afghanistan. A cominciare proprio dalla condizione di milioni di donne finalmente libere di istruirsi, di lavorare, libere soprattutto dalla violenza maschile, libere di muoversi, di vestirsi, di agire e di parlare in pubblico. Libere anche di fare politica come dimostra un numero di elette in proporzione più alto di quello di alcuni parlamenti occidentali. Le cure sanitarie, la crescita commerciale, economica e occupazionale è stata senza precedenti e parallela all’instaurarsi insieme con l’embrione di un sistema giudiziario anche di una qualche tutela di diritti umani, di diritti politici e civili. Certo, come in precedenza, scandalose inefficienze e scandalosa corruzione ad ogni livello hanno continuato ad accompagnare i faticosi progressi di questi vent’anni e se non si può escludere che il volume di trasferimenti sotto forma di doni, di finanziamenti, di speculazioni dall’estero abbiano alimentato nuove forme di corruzione è certo che non sono venute meno quelle più antiche e più radicate nei costumi locali a cominciare dalla coltivazione del papavero che da decenni fa dell’Afghanistan il primo produttore mondiale di oppio.
Perché gli afghani non hanno combattuto
Un’analisi particolareggiata meriterebbe l’impegno profuso per costituire e organizzare l’esercito afghano che avrebbe dovuto proteggere il nuovo stato dai suoi nemici e che viceversa è collassato prima di combattere. Oggi apprendiamo che le stime che lo calcolavano forte 350.000 soldati erano del tutto aleatorie e che al massimo poteva contare su non più di 60/80.000 effettivi. Alcuni generali erano così corrotti da rubare non solo su viveri, divise, approvvigionamenti ma anche sulla paga dei sottoposti. Un paese diviso in tribù ed etnie abituate a combattersi, ufficiali superiori usi a comportarsi come capi clan, a dispensare favori ai propri fedeli e maltrattamenti agli estranei non fornivano premesse incoraggianti, eppure si resta sbalorditi nello scoprire che americani e anche europei in veste di addestratori e tutori dell’esercito afghano non si siano accorti di nulla e non abbiano fatto nulla per prevenire un disastro annunciato.
Il ruolo del pakistan
Ma torniamo a oggi e a Biden. Se scopo dell’occupazione americana era solo la vendetta per le Torri gemelle la missione poteva dirsi compiuta con la cattura e l’uccisione di Osama Bin Laden il 2 maggio 2011. Senonché questa interpretazione – oggi clamorosamente smentita dall’evidenza che in Afghanistan sono tuttora attive non una ma due organizzazioni terroristiche – era poco convincente già nel 2011. Basti riflettere alla circostanza che l’esecuzione per mano dei Navy Seals e della CIA di Osama Bin Laden, ispiratore e mandante – si suppone non solitario – dell’attacco all’America e della strage alle Torri Gemelle di New York – non
avviene nell’Afghanistan occupato ma nel confinante Pakistan – paese ufficialmente alleato degli USA – non lontano dalla capitale Islamabad in un vistoso complesso edilizio prospiciente un’accademia militare.
Le autorità pakistane ovviamente esclusero ogni loro coinvolgimento nella decennale latitanza di Bin Laden, ma i sospetti che da sempre gravano sui loro rapporti con i talebani oltrepassano la conclamata ambiguità dei loro servizi segreti di sicuro non privi di padrini ideologici e politici. Né basta evocare la comune appartenenza di entrambe le popolazioni all’etnia maggioritaria pashtun, o la joint venture nella raffinazione pakistana del papavero afghano. Il vero legame tra Kabul e Islamamad è politico nel senso che entrambe le capitali erano e sono sintonizzate tra loro, e non solo tra loro, sullo stesso islam cioè sulla stessa visione politica trasversale a diverse nazioni mussulmane.
Il magma islamista e la sua ambizione
Che si tratti di monarchi assoluti, di presidenti eletti con le buone e più spesso con le cattive, di coriacei dittatori, di comandanti militari o paramilitari, al di là di tutte le enormi differenze storiche, nazionali e religiose, al di là di tutti i fossati di ricchezza e di sviluppo che li dividono c’è in molti leader islamici un retroterra trasversale di natura fideistica e comunitaria, quello di voler essere o almeno di voler apparire seguaci, interpreti, combattenti con qualunque mezzo per la riscossa dell’ Islam, la più potente religione mondiale. Nessun leader può fare a meno di questo immenso giacimento identitario. Crogiuolo e magma incandescente di potere e di ricchezza, di miseria, di rabbia e di frustrazione l’islamismo continua ad accendere in tanti, diversi luoghi fisici e nello psichismo di massa una volontà di riscatto e l’ambizione a una leadership mondiale. Da Khomenei che per primo fece divampare il bagliore della guerra santa a israele e al Grande Satana americano, a Bin Laden che squarciò il cielo di Manhattan e invocò dai suoi pari “dateci almeno un Califfato”, al sanguinario Daesh l’auto proclamato stato islamista siriano iracheno, alle propaggini dell’Isis in Africa, all’ Afghanistan talebano, al Pakistan nuclearizzato, all’Iran che vuole la bomba, a Erdogan che vuol farsi sultano, l’Islam ribolle di guerre intestine, di rivalità secolari, di squilibri e diseguaglianze abissali eppure è unito dal sogno e dalla retorica di un riscatto così grande da islamizzare il mondo intero.
Viceversa l’occidente si interroga, si divide e si perde disputando e divagando se la democrazia sia o non sia una merce esportabile quando è del tutto evidente che quasi ogni guerra dall’epoca moderna in poi si conclude con l’abbattimento di un regime e la necessità di metterne in campo uno nuovo.
Cinque presidenti cinque politiche
Biden si è assunto anche troppe responsabilità coprendo la pessima prova degli apparati sicurezza ma non è certo il più colpevole. All’inizio degli anni ’90 dopo aver sostenuto la lotta dei mujiaddin contro l’invasore russo gli USA di Clinton con il Pakistan, l’Arabia Saudita – e con Bin Laden – foraggiano e armano proprio i talebani del mullah Omar e li portano alla vittoria in una guerra civile costata 100.000 morti. Nei venti anni successivi all’attacco alle Torri Gemelle, due presidenti repubblicani hanno impresso due opposte, violente torsioni alla politica estera e di difesa degli USA. Tra il 2001 e il 2003 Bush dichiarata guerra al terrorismo invade e occupa l’Afghanistan e l’Iraq – salvo evocare il ritiro delle truppe alla fine del suo mandato. Dopo di lui Obama, schernito come “guerriero riluttante”, ha pur deciso di restare altri otto anni a Kabul e nonostante il parere avverso del suo vice e di altri esponenti della sua amministrazione ha insistito nel contrasto ai talebani e negli sforzi di Nation Building. Ad aver innestato la marcia indietro è stato Trump. Disimpegnando la nazione più potente dal dovere di promuovere un ordine in quella parte di mondo ha negoziato un ritiro con tanto di data di scadenza improvvisamente riconoscendo ai talebani la rappresentanza del popolo afghano e lo status di potenza vincitrice. Di più, non ammettendo al negoziato il legittimo governo di Kabul e il presidente Ghani – peraltro un cittadino americano con doppio passaporto scelto dagli stessi americani, Trump ha delegittimato in un sol colpo l’Afghanistan forgiato dagli USA e vent’anni di combattimenti, di impegni e di sacrifici dell’Occidente unito. Da tutte queste mosse ondivaghe e contradditorie emerge il profilo di una grande nazione divisa e instabile negli indirizzi fondamentali di politica estera e di sicurezza. Indirizzi ormai dettati non più da una visione di lungo periodo, nemmeno da un costante contrasto e contenimento dell’islamismo radicale e terrorista. A dettare le decisioni più importanti sono gli umori dell’opinione pubblica interna che come spesso accade in tutto il mondo libero sono insufflati non da responsabilità e lungimiranza ma da calcoli economici, dall’ansia per il proprio tenore di vita e dalla paura di dover contare i propri morti.
Libertà e democrazia valgono un combattimento?
Ora, a parte il fatto che in un sol giorno di caotica evacuazione – sarebbe più onesto chiamarla fuga – si è visto che il terrorismo in Afghanistan non è finito e che i talebani non ne hanno il monopolio mi chiedo anch’io come fa Anne Applebaum con la consueta schiettezza non quanto costi ma se per gli USA e per l’Occidente la libertà e la democrazia siano ancora un valore per cui combattere.
Ce lo chiediamo perché se è presto per capire le conseguenze su larga scala della fuga dall’Afghanistan e dell’indebolimento americano non è presto per accogliere onorevolmente i profughi (come sta facendo l’Italia), sicuri che tra i molti che vorranno solo dimenticare ci saranno quanti sono interessati a fare del proprio esilio una forma di resilienza e perciò saranno i più attenti a collaborare anche nell’individuazione di eventuali infiltrati terroristi. Non è presto anche per rassicurare chi convive con vicini molto aggressivi tali gli ucraini con Putin o i cittadini di Hong Kong e di Taiwan con Xi Jinping. Non è presto per scoraggiare la diffusione in medio oriente e in Africa del virus afghano, insomma per allontanare dall’orizzonte il funesto presagio di un occidente in ritirata da tutti i fronti più caldi e mostrare con le parole e con i fatti di conoscere il vecchio proverbio: “Chi si fa pecora il lupo se lo mangia”.
Europa: sussulti o presa di coscienza?
La campana di Kabul suona anche per noi, noi italiani ed europei. Da alcune prese di posizione si direbbe che qualcuno abbia sentito i suoi rintocchi. Penso all’iniziativa di Mario Draghi di coinvolgere anche Russia e Cina in un G 20 dedicato all’Afghanistan sia per quanto riguarda i rifugiati, sia per contrastare il terrorismo islamista che vi sta installando una nuova filiera dell’ISIS. Penso anche all’idea – ancora molto vaga – di Macron e di Johnson di costituire in Afghanistan una Safe o Buffer Zone, una zona cuscinetto, da dove organizzare l’esodo – in un primo tempo verso paesi confinanti – delle centinaia di migliaia di donne e uomini che non vogliono vivere in quello che è ridiventato il paese dei talebani.
La questione ha fatto capolino persino nel dibattito elettorale tedesco, ma solo Laschet, il candidato CDU, quello messo peggio nei sondaggi, ha detto che la Germania deve aumentare il suo impegno militare. Scholz leader della SPD dato in ascesa ha preso tempo e la candidata dei Verdi Baerbock ha detto no. Ancora non è chiaro se quelli europei siano sussulti emotivi nell’immediatezza del trauma psicologico seguito alla fuga da Kabul o l’inizio di una presa di coscienza. Visti i precedenti il pessimismo è d’obbligo, eppure dove non sono riuscite le pressioni americane potrebbe a una reazione il senso di insicurezza trasmesso dalla ritirata e dal vuoto che hanno lasciato. In ogni caso per dare il senso di una vera revisione della politica di sicurezza europea bisognerebbe innanzitutto far tabula rasa di velleità e fantasie come quella di chi dando per morta la NATO immagina una difesa europea del tutto nuova e del tutto autonoma. Come crederci se finora nessun paese europeo ad eccezione della Francia ha mantenuto l’impegno concordato di destinare alla difesa almeno il 2% del proprio bilancio? Come crederci se nessun leader europeo di centro, di destra o di sinistra ha mai osato dire che bisogna aumentare le tasse o prelevare fondi da altre destinazioni per implementare la nostra capacità difensiva? Solo ove questa volontà politica fosse chiara e determinata avrebbe senso discutere se destinare i maggiori investimenti alla NAT0, a un nucleo di difesa europea o a entrambi. Per intanto il massimo sforzo deciso dall’Unione prefigura la costituzione di un’unità di pronto intervento forte di soli 5.000 uomini (si dice pronto intervento quando non si vuol dire la parola combattimento). Davvero troppo poco e anche questo poco è tutt’altro che certo avrà il consenso di tutta l’Unione.
Evitare l’urto tra le potenze
Eppure, lo stato del mondo e la parte dell’Europa nella globalizzazione dovrebbero farci ragionare con più lucidità e indurci a scelte più coraggiose, cioè responsabili e lungimiranti. Se guardiamo al mondo nel suo assieme la globalizzazione presenta un saldo nettamente positivo segnato dall’emersione dalla povertà e dalla crescita impetuosa di interi continenti risvegliati da un sonno secolare proprio grazie alla globalizzazione. Se viceversa guardiamo alla parte più ricca del pianeta – Stati Uniti e Europa per primi – la globalizzazione ha significato arricchimento esponenziale dei ricchi e ricchissimi e impoverimento dei ceti medi e dei più poveri. (L’Italia non fa eccezione). Ne è derivata, in occidente, una sfiducia tracimata in risentimento, in rifiuto e in disprezzo della democrazia liberale. Poi abbiamo visto sprigionarsi una ancora più corrosiva e pericolosa: il liberismo aveva scartato l’elemento democratico dopo aver distrutto quello socialista. Politici senza scrupoli e senza coscienza fomentado la reazion della classe media impoverite e se ne sono approriati rivolgendola demagogicamente contro le elite. E qui hanno commesso non uno ma più errori: non si sono limitati a contestare le elite del poter del potere e del denaro ma hanno attaccato simultaneamente anche i vasti mondi del merito, della competenza, della cultura. E’ stato questo il brodo di coltura dei nazionalpopulisti con le loro politiche, le loro reazioni rabbiose, i loro rimedi illusori e il loro vero unico estro, quello naturale di confondersi con il qualunquismo, il moralismo, il giustizialismo e farsene piedistallo di ambizioni politiche. Non si può negare che a spalancare la scena del mondo ai nazional populisti sia stata proprio la globalizzazione, l’indigeribile ingiustizia di veder una minoranza di ricchi e potenti che continua a arricchirsi mentre una cerchia molto più ampia di classi medie, (numeri importanti che includono fasce di popolazione molto diverse delle evolute società dell’occidente e dei loro refoulé, respinti.
Paranoie, suprematismi e rischi globali
Dopo la fuga da Kabul è diventato quasi naturale sentire e leggere chi s’interroga: ma davvero è a rischio la supremazia occidentale? Si sta forse avverando la profezia di Lenin che parlando da asiatico più che da europeo profetizzò “i capitalisti ci venderanno anche la corda per impiccarli?” O siamo in preda a una paranoia, a una malattia senile della psiche e della cultura occidentali che non accettano di convivere alla pari con chi si è liberato dal sottosviluppo? Il suprematismo bianco prova che questa paranoia – l’altra faccia della cultura della resa – esiste e moltiplicando artificialmente le paure dell’occidente rifornisce di alibi le tentazioni aggressive della Cina e della Russia.
Come scongiurare i rischi di un urto devastante tra le grandi nazioni?
E’ credibile che come un tempo la mano invisibile del mercato oggi sarà la globalizzazione a disegnare un ordine? E’ possibile un ordine mondiale, un ordine economico e politico, senza più potenze egemoni? O il buon senso e l’esperienza – la faccia buona della realpolitik – hanno ragione a ricordarci che ci sarà sempre una gerarchia di grandi potenze, potenze regionali e piccole patrie? Ma poi, quale speranza possiamo nutrire che un nuovo ordine non consista in una nuova spartizione del mondo? Penso ai popoli che ancora lottano per la loro terra, per la loro indipendenza, per preservarle o per conquistarle: vogliamo ascoltarli, aiutarli o ignorarli e chiudere gli occhi davanti alle sofferenze perché il loro agitarsi minaccia la stabilità?
L’economia non ha risposte a questi problemi e quando prova a imporsi li aggrava, la politica può almeno attenuarli mentre cerca le soluzioni.
Biden e l’Alleanza delle democrazie
Pochi mesi fa nel corso del G7 – invitati anche India, Australia, Corea del sud e Sud Africa – e poi dell’incontro con l’Unione Europea il presidente Biden ha lanciato un messaggio importante. Rompendo con l’isolazionismo muscolare e imbelle di Trump non solo ha rivendicato l’approccio multilaterale ai problemi del mondo ma ha trovato – o ritrovato – il filo di una storia e di un’alleanza data per dispersa o esaurita: l’alleanza delle democrazie. Nelle sue parole è risuonato qualcosa di più dell’intento di rivitalizzare l’Alleanza Atlantica: “Tutti hanno compreso – ha detto – la serietà delle sfide che fronteggiamo e la responsabilità delle nostre orgogliose democrazie di farsi avanti e produrre risultati per il resto del mondo”. Biden non li menziona ma senza dubbio i valori sono quelli dell’occidente, della sua costituzione ideale e materiale. Quanto alle sfide da fronteggiare sembrano essere quelle poste dalle autocrazie – Cina, Russia, Iran anzitutto. Credo che l’Alleanza delle democrazie sia una buona idea, una bussola necessaria, una forza di dissuasione di minacce e azioni ostili per esempio nel campo della cyber security. Diversamente, se l’Alleanza dovesse servire a piegare e allineare gli interessi economici dei suoi membri a quelli degli Stati Uniti non farebbe molta strada. Come già si è visto la Germania di Angela Merkel non intende rinunciare al gasdotto Nord Stream con la Russia e la Francia per bocca di Macron ha fatto sapere di “essere certamente con gli USA se si parla di sicurezza ma non è disponibile ad azzerare i propri rapporti economici con Mosca e Pechino”. La questione è ulteriormente complicata dal fatto che sempre più spesso sicurezza ed economia si intrecciano, basti pensare alla corsa alle materie prime, alla questione 5G, alle batterie e ai microprocessori necessari per fabbricare auto e telefonini e tanti altri strumenti.
Internazionalismo democratico e socialista
Se vogliamo evitare l’urto tra le nazioni più potenti non possiamo affidarci alla globalizzazione senza regole e poi replicare il paradosso dell’America di Trump che moltiplicava i dazi mentre la Cina comunista pretendeva libero mercato. Se non vogliamo lacerare e perdere le nostre nazioni non possiamo insistere nel liberismo degli ultimi venti anni. La pandemia e il surriscaldamento climatico non si vincono con la lotta tra nazioni. Si vincono facendo crescere la consapevolezza che tutti quanti siamo costituiamo “la nazione umana” e condividiamo la stessa sorte. Un mondo migliore è possibile, per avvicinarlo si deve lavorare dal basso e dall’alto, un rinnovato internazionalismo democratico, socialista e ambientalista può assumere le sfide di quest’epoca: correggere e regolare la globalizzazione dei più forti e dei più ricchi, fare opera di giustizia sociale e di genere, impedire che la sfida tra le nazioni degeneri in guerra, controllare e contenere l’aggressività delle autocrazie, diffondere universalmente – a tutti e ovunque nel mondo – con i diritti umani fondamentali più conoscenze, più saperi, più cultura, più solidarietà.