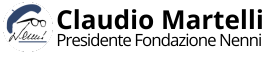Nel 1968 durante la missione spaziale Apollo 8 che orbitò per dieci volte intorno alla luna William Anders, uno dei tre astronauti, scattò una foto che immortalò lo spettacolo della terra che sorge, Earthrise. Tra miliardi di pianeti che affollano l’universo simili a sterili “palle di roccia la terra risaltava per i suoi colori: il verde della vegetazione, il bianco delle nuvole, il blu dell’acqua”.
Quei tre colori esistono grazie alle piante, la forma di vita di gran lunga più diffusa e la più importante perché da essa dipendono tutti gli altri esseri viventi. Sono infatti le piante a produrre tutto l’ossigeno presente sul pianeta e tutta l’energia consumata dagli altri esseri viventi, umanità compresa. “Noi esistiamo grazie alle piante” eppure delle piante sappiamo pochissimo, quasi nulla”.
È l’incipit dell’ultimo libro di Stefano Mancuso che con un “giocoso esercizio” tra scienza e filosofia tratta le piante come una Nazione, “ossia una comunità di individui che condivide l’origine, i costumi, la storia, le organizzazioni e le finalità”.
Osservandole, studiandole, amandole Mancuso è giunto a una conclusione rivoluzionaria: le regole che organizzano il regno vegetale “non valgono per una singola specie o per pochi gruppi di specie”, ma possono – e dovrebbero – essere intese come “una costituzione valida per tutti gli esseri viventi e per tutta la vita nel suo assieme”. Il comandamento riguarda soprattutto gli uomini che causa la loro natura predatoria e la loro ignoranza “sono riusciti nella difficile impresa di cambiare così drasticamente le condizioni del pianeta da renderlo un luogo pericoloso per la loro stessa sopravvivenza”.
Come quella italiana del 1947 la costituzione che vige nel regno vegetale ha i suoi principi fondamentali. Il primo e il più solenne afferma: “La terra è la casa comune della vita e la sovranità appartiene ad ogni essere vivente”.
In effetti allo stato delle nostre conoscenze, ma anche dei più complessi calcoli probabilistici, l’ipotesi che in altri pianeti esistano forme di vita appare… del tutto improbabile. Così stando le cose, la terra e i suoi esseri viventi sono i “beneficiari di un enorme, incommensurabile, colpo di fortuna” quello di formare l’unico pianeta che vive. “Fatta chiarezza su questa immensa fortuna si tratta di capire a chi appartenga e la risposta più ovvia è che appartiene all’uomo”.
“La Terra è cosa nostra”, “l’uomo è il signore della terra” ripetiamo in coro da millenni e, fino ad oggi, ne siamo stati così persuasi che “ne abbiamo diviso la superficie in Stati e ne abbiamo assegnato la sovranità ai diversi gruppi umani, che a loro volta l’hanno affidata a un limitatissimo gruppo di persone che sarebbero titolari e responsabili dell’unico pianeta dell’universo sul quale esiste la vita”. Mancuso confessa che una simile conclusione e regole così pazzesche gli appaiono talmente “assurde che a pensarci mi prende come un capogiro”. Su cosa si fonda la presunzione che gli uomini siano i signori della terra? Sul numero degli esseri umani – opzione democratica?
Certamente no considerato che i sette miliardi di umani sono appena lo 0,1 per cento degli esseri viventi a fronte del 2 per cento rappresentato da tutti gli animali e dell’80 per cento rappresentato dalle piante. Rimane la seconda giustificazione – opzione aristocratica – secondo la quale l’uomo è migliore di qualunque altro organismo vivente.
In effetti, chi ne ha mai dubitato? “Possiamo essere ambientalisti, fricchettoni, verdi, mistici, materialisti, religiosi, atei, anarchici o realisti, ma su una cosa siamo tutti d’accordo: siamo migliori di scimmie, mucche, albicocchi, felci, batteri e muffe… l’affermazione sembra così evidente da non aver bisogno di essere ulteriormente sostanziata”. La specie umana è la migliore di tutte “perché il nostro grande cervello ci permette di fare cose che sono impossibili” a qualunque altra specie.
Era proprio qui che Mancuso voleva condurci con la sua maieutica, nutrita di antico scetticismo e di moderna filosofia del linguaggio. Migliori in che senso? In una gara di velocità migliore è chi corre più veloce, come “Federer è migliore di qualunque altro tennista, Dostoevskij di qualunque altra cosa. Ma nella storia della vita, cosa vuol dire migliore?” Se ancora vale il primum vivere “l’organismo migliore è il più adatto a sopravvivere”.
Ma allora, rispetto alla specie dell’homo sapiens, le specie animali offrono abbondanza di performances migliori: “si va dai dieci milioni di anni degli invertebrati a un milione di anni dei mammiferi”. Non basta, sempre secondo il criterio enunciato, “le piante sopravvivono molto più a lungo degli animali” e tanto dovrebbe bastare per sovvertire la celebre gerarchia stabilita da Linneo, il più grande botanico moderno che collocò le piante al gradino più basso degli esseri viventi e l’homo sapiens al più alto.
Ma se il nuovo, ben meditato criterio è quello della vita – la vita che è “durata” – anche il primato, il trono, dell’uomo traballa. Non a caso il comune sentire e non solo il ragionamento scientifico conducono alla stessa conclusione. Chi infatti, tra gli umani, scommetterebbe che la specie umana durerà anche solo “per altri 100.000 anni?”
Come mai di fronte a una domanda così semplice all’improvviso evaporano tanto l’ottimismo, quanto la presunzione che ci rendevano così sicuri di essere i migliori tra tutti gli esseri viventi? Secondo Mancuso “dipende dai disastri che siamo riusciti a combinare sul pianeta in un lasso di tempo così incredibilmente breve come gli ultimi 10.000 anni, ossia dal momento in cui l’homo sapiens creando l’agricoltura ha iniziato a incidere profondamente nell’ambiente in cui vive”.
In altre parole la sfiducia nella durata della nostra sopravvivenza consiste esattamente in questo, “che abbiamo ben presente che il nostro grande cervello, di cui siamo così orgogliosi, è stato in grado di produrre, oltre alla Divina Commedia, anche una serie di innumerevoli pericoli che in qualunque momento potrebbero spazzarci via dal pianeta…
E se svanissimo domani, tra mille o fra centomila anni cosa rimarrebbe della Cappella Sistina, della Venere di Milo, della teoria della relatività, della Divina Commedia, delle piramidi e di tutti i nostri ragionamenti? Nulla.” A chi importerebbe di queste meraviglie una volta che fossimo tutti morti?”. Mancuso non indugia in ipotesi tragiche, non interroga le promesse di vita ultraterrena delle religioni, non cerca consolazioni filosofiche, né vie di fuga affidate a farmaci che allunghino l’esistenza individuale.
Tutto al contrario di chi si arrende Mancuso cerca la vita – la “durata” che è vita – la cerca sulla terra e nella natura, la cerca per la specie umana non per singoli beneficiari, la cerca con gli strumenti di una conoscenza umile come la botanica che si piega a capire i segreti di esseri umili come le piante che nella loro organizzazione custodiscono i segreti della più straordinaria longevità.
Prima di addentraci nella straordinaria pars construens del suo pensiero sento il bisogno di una pausa per tentare un’interpretazione della pars destruens. Quel che Mancuso ci ha detto sin qui basta a farci considerare più che plausibile l’inevitabilità e l’inesorabilità del nostro destino ove non assumessimo paradigmi diversi, carte nautiche aggiornate e una nuova rotta.
Ciascuno, ovviamente, è libero di riflettere e congetturare su cosa ci aspetta se restiamo prigionieri della nostra superbia, di quella cieca presunzione ed avidità che mentre ci ha reso illusoriamente signori della natura e della terra, i “migliori” nel senso più banale, ovvero i più potenti tra tutti gli altri esseri viventi, ci ha anche tolto la fiducia nella sopravvivenza della nostra specie. È come se avessimo scambiato la vita della specie umana e la sua possibile durata in cambio del nostro potere individuale, al massimo di quello della nostra generazione e della nostra nazione.
È come se avessimo proiettato l’ombra del destino consapevolmente breve di noi individui destinati a morire nell’arco di pochi decenni sulle possibilità di sopravvivenza dell’intera specie umana.
Che c’importa di quel che accadrà quando noi non ci saremo più? La vita è questa godiamocela o, tutto al contrario, sacrifichiamola pur di conquistarci quella d’oltretomba, la sola che conti. Sballottata, divisa, assediata dai due opposti estremi dell’individualismo l’umanità non ha avuto tempo né modo né volontà di pensarsi come specie, di avere coscienza della specie.
I più lungimiranti si sono preoccupati di figli e nipoti, i più talentuosi tra i condottieri e i geni di creare o costruire opere meno effimere della loro esistenza, ma almeno fino a quando il destino della specie e della Terra che la ospita non è entrato nella zona del pericolo imminente, incombente e presto irreversibile nessuno se n’è preso cura. E molti, troppi ancora, vivono come sonnambuli o come schiavi nella caverna.
Ora possiamo riprendere il cammino con Mancuso come guida, un cammino tutto scritto dentro e non fuori i confini della storia naturale, un cammino tanto umile, tanto amabile e tanto rivoluzionario da poter almeno allontanare i pericoli di una più rapida estinzione se solo volessimo e sapessimo farci guidare non dalla nostra inesausta brama di potere – di dominio, di profitto – ma dalla nostra naturale connessione con la vita degli altri e di tutti gli esseri viventi. Innanzitutto dobbiamo smettere di comportarci come apprendisti stregoni. Chi altera gli equilibri naturali ottiene successi effimeri e distruzioni permanenti. Mancuso ne fornisce un’antologia. Gli inglesi volendo riprodurre il meraviglioso rosso carminio monopolio degli spagnoli conquistadores anche delle tecniche azteche che sfruttavano la cocciniglia e il fico d’India ne apprestarono coltivazioni di massa in Australia. Senonché in Australia le cocciniglie non sopravvissero mentre i fichi d’India si espansero inarrestabili su milioni di ettari desertificando fattorie, pascoli, aree agricole, scacciando i coloni e impedendo ogni attività produttiva.
“Ma nessun disastro naturale, fra quelli provocati dall’uomo a seguito di decisioni avventate basate su una scarsa conoscenza delle relazioni naturali, potrà mai rivaleggiare con quanto combinato da Mao Ze-Dong alla fine degli anni ’50 con il Grande Balzo in Avanti”.
Bisognava limitare la diffusione degli agenti che diffondevano le malattie: le zanzare la malaria, i topi la peste, le mosche le infezioni e, infine, i passeri che mangiando la frutta e il riso affamavano il popolo. Così cominciò la grande campagna contro i quattro flagelli a suon di pesticidi e di rumori di massa e sventolamenti di lenzuola per scacciare i passeri. La campagna ebbe successo, ma spariti i passeri si moltiplicarono gli insetti e le locuste che distrussero gran parte delle colture causando carestie e la morte di un numero di persone tra i 20 e i 40 milioni.
“Giocare con qualcosa di cui non si capiscono i meccanismi è pericoloso. Sono le relazioni tra gli esseri viventi a generare le comunità e sono queste a perpetuare la vita. L ’intero p ianeta a ndrebbe considerato come un unico essere vivente – è la teoria di Gaia – che dispone di meccanismi equilibratori capaci di smorzare le oscillazioni di un ambiente continuamente mutevole”.
Gli animali vedono con gli occhi, sentono con le orecchie, respirano con i polmoni, ragionano con il cervello… le piante vedono, sentono, respirano e ragionano con tutto il corpo… L’essere costituiti con un cervello che presiede alle funzioni dei vari organi specializzati ha influenzato qualunque tipo di organizzazione e struttura l’uomo abbia mai ideato. Replichiamo dappertutto questa organizzazione centralizzata e verticistica.
Le nostre società, le nostre aziende, gli uffici, le scuole, gli eserciti, le associazioni, i partiti, tutto è organizzato secondo strutture piramidali. Anche i computer sono dei semplici analoghi, sintetici di noi stessi: un processore che mima le funzioni del nostro cervello, che governa delle schede (hardware) che imitano le funzioni dei nostri organi. L’unico vantaggio di questo tipo di organizzazione è la velocità, ma questo vantaggio è annullato dalla necessità di un’organizzazione burocratica che trasmetta gli ordini ma che non solo è soggetta ad errori, ma consuma il tempo attivando i comandi lungo la catena gerarchica piramidale. Secondo il principio di Peter scoperto nel 1969 “in una gerarchia ogni dipendente tende a salire – a essere promosso – fino a raggiungere il suo livello di incompetenza”.
La stessa idea l’aveva avuta un secolo prima Ortega y Gasset, un autore molto amato da Luciano Pellicani, che l’aveva così formulata: “Tutti i dipendenti pubblici dovrebbero essere retrocessi al loro livello immediatamente più basso, poiché sono stati promossi fino a diventare incompetenti.”
Non oso immaginare le reazioni corporative, sindacali e di casta ove ci si provasse a sperimentar anche solo in un singolo ufficio un simile programma. In Italia, oltre tutto, prevalgono le categorie di pubblici funzionari – burocrati, militari, magistrati – che avanzano in carriera in virtù di automatismi o per anzianità, indipendentemente dal merito cioè dalle competenze acquisite. L’incompetenza non è l’unica pecca delle “organizzazioni animali, burocratiche, centralizzate, piramidali e con una catena di comando. Le burocrazie tendono a espandersi senza limiti perché i loro membri tendono a moltiplicare i subordinati e non i possibili rivali”.
Sino al punto – già descritto da Max Weber – in cui ogni burocrazia cessa di servire la società che l’ha creata diventando fine a se stessa, crescendo come un corpo estraneo, prendendo provvedimenti che la proteggono e imponendo regole che servono solo a giustificare le proprie dimensioni.
“Possibile che non riusciamo a immaginare niente di diverso, come potrebbero essere, ad esempio, delle organizzazioni diffuse costruite come il corpo di una pianta? Internet, il simbolo stesso della contemporaneità, è costruito come una pianta: completamente decentralizzato, diffuso, formato da un elevatissimo numero di nodi identici e ripetuti, senza organi specializzati.
Ebbene “l’intreccio sotterraneo tra le radici delle piante è fatto anch’esso di moduli che si ripetono infinite volte” – in un solo albero possono essere centinaia di miliardi – e formano strutture sempre più complesse. Queste strutture a rete “diffondendosi nel suolo ed esplorandolo alla ricerca di nutrienti e dell’acqua” sono talmente complesse da assomigliare alle nostre reti neurali, ai cosiddetti “sistemi” delle nostre tecnologie più sofisticate, tali gli apparati diagnostici e i metodi di intelligenza artificiale.
“Non solo le radici, anche le chiome di un albero replicano lo stesso modello organizzativo diffuso opposto a quello centralizzato animale. La Nazione delle piante si è così liberata per sempre dei problemi tipici delle organizzazioni animali: accentramento, sclerosi, inefficienza. Negli ultimi anni modelli simili a quelli delle piante – senza centro di comando – si vanno diffondendo velocemente dando vita a forme diffuse di decisione soprattutto a livello periferico cioè lì dove devono essere per risolvere con precisione i problemi: dove le informazioni sono maggiormente disponibili e le necessità chiare”.
Quelle di Mancuso sono tutt’altro che riflessioni solipsistiche.
Il vecchio mondo di un potere elitario e inaccessibile e di burocrazie elefantiache, almeno in occidente è sempre più spesso sfidato – nel bene e nel male – dal mondo nuovo che cavalca la rivoluzione tecnologica in atto. L’esperienza ci ha insegnato a non farci abbagliare da tutto ciò che è nuovo perché è nuovo e sino a disprezzare tutto il passato come se niente di ciò che era e ancora è meritasse di essere conservato. Quel che è indubbio è che la rivoluzione digitale unita alla nuova coscienza ecologica e al protagonismo femminile generando forme diverse di partecipazione di mobilitazione politica tracciano nuovi confini anche ai perduranti conflitti di potere.
“La Terra, unico posto dell’universo in grado di ospitare la vita è considerata dall’uomo come una semplice risorsa, qualcosa da mangiare e da consumare per trarne energia”. Come “un leone col suo pezzo di savana” l’uomo è indifferente al fatto che questa risorsa possa terminare e noi con essa. “L’uomo è il più compiuto di tutti i predatori, più pericoloso di tutte le altre specie”. Le passate estinzioni di massa comunque causate non hanno mai raggiunto i livelli apocalittici di oggi e si sono manifestate lungo un arco di milioni di anni. L’attività umana, al contrario, sta concentrando la sua letale influenza sulle altre specie viventi in una manciata di anni”. I concetti di Stefano Mancuso riecheggiano su questo punto tanti precedenti allarmi e le parole assomigliano molto anche a quelle che usai nel lontano 1987.
Con un’inquietante differenza: allora io parlavo di un pericolo incombente “in una manciata di decenni” oggi Mancuso parla di “una manciata di anni”. Dal 1988, da quando l’Assemblea generale dell’ONU votò la risoluzione sulla Tutela del clima globale per le generazioni presenti e future dell’umanità. Da allora troppo poco è cambiato e solo nell’ultimo anno mentre complessivamente le emissioni di CO2 sono cresciute del 40 per cento. Cosa possiamo fare? “Lasciar fare alle piante” risponde Mancuso e prima di tutto bloccare ogni deforestazione (i vari Bolsonaro) coprire di piante tutta la superficie del pianeta disponibile e quella recuperabile dalla rigenerazione delle città e delle aree ex industriali. “Senza una sufficiente quantità di foreste non esiste alcuna possibilità di invertire il trend di crescita della CO2”.
Le ulteriori raccomandazioni di Mancuso non contengono novità rispetto al livello raggiunto dalla cultura ecologista ancorché spesso siano meglio circostanziate sorrette da esempi chiari e scritte in modo più elegante.
Meno persuasivo mi sembra invece il richiamo, in sé giusto, a non cercare una crescita illimitata a fronte di risorse limitate. Mancuso punta il dito sulla crescita non demografica ma dei consumi, eppure le due cose non sono separabili anche supponendo il graduale imporsi di modelli alternativi di sviluppo. Così l’esempio del petrolio giudicato come una risorsa in esaurimento – a fronte della scoperta di sempre nuovi giacimenti e di nuove tecniche di estrazione (lo shale) – appare un argomento debole oltre che contraddittorio con l’assunto generale. La riduzione dei consumi di idrocarburi è necessaria per fermare l’avvelenamento non perché manchi il veleno.
Del tutto nuovo, ancora una volta, è invece l’invito a guardare le piante. A differenza di quel che pensava Linneo le piante “sentono” anche più degli animali. Proprio perché “radicate nella terra a differenza degli animali che spesso risolvono i problemi muovendosi, prendendo le distanze dal pericolo, le piante – che pur si muovono, non individualmente, e migrano lentissimamente generazione dopo generazione prendendo possesso di nuovi territori -, percepiscono luce, temperatura, gravità, gradienti chimici, campi elettrici, tocco, suono ecc. dunque sono esseri estremamente sensibili all’ambiente”. Dunque, guardiamo al loro comportamento e alla loro plastica flessibilità.
Se l’ambiente diventa sfavorevole le piante “Riducono la loro taglia, si ispessiscono, si assottigliano, si avvolgono, curvano, salgono, strisciano, modificano la forma del loro corpo, interrompono la propria crescita, fanno tutto ciò che è necessario perché il loro equilibrio con l’ambiente sia il più stabile possibile. Qualcosa che dovremmo al più presto iniziare a fare anche noi, con umiltà”. Concludendo il suo excursus naturalista e antropologico Mancuso non perde l’occasione per una polemica – quanto mai attuale – contro il darwinismo sociale vecchio di più di un secolo eppure spaventosamente rilanciato e potenziato dall’esasperato liberismo della competizione economica globale. Darwinisti senza e contro Darwin erano gli pseudo scienziati (Gobineau, Galton, T.Huxley,) che tradussero a loro comodo la teoria dell’evoluzione naturale in termini di lotta per il primato non del “migliore”, ma del più forte, del più intelligente, del più grosso o del più spietato.
“Sentir parlare di legge della giungla in ambiti quali i mercati economici, la politica delle nazioni, l’ambiente di lavoro, addirittura lo sport e la scuola è ormai un luogo comune. Quasi l’unica maniera di intendere le relazioni tra gli esseri viventi. Ogni alternativa è considerata poco meno che utopica”. Naturalmente Darwin non si è mai sognato di mettere in circolazione simili sciocchezze. Le relazioni fra i viventi sono incredibilmente più complesse e governate da forze molto diverse dalla semplice competizione immaginata dai darwinisti sociali.
Con molto piacere ho visto che all’opposto della teoria dell’uomo lupo per l’altro uomo Mancuso recupera le idee di un autore che ho molto amato nella mia giovinezza. Petr Kropotkin. Nel suo capolavoro, Il mutuo appoggio come fattore dell’evoluzione, Kropotkin individua nella capacità degli individui di cooperare il vero motore dell’evoluzione. Prego i liberisti di non agitarsi: non stiamo negando che anche la competizione, l’emulazione, la gara possano dispiegare nella vita effetti benefici, neppure nego che la competizione e la cooperazione convivano nella natura dei singoli e nell’insieme della società. La tesi di Kropotkin, mia di Mancuso e di molti altri soprattutto socialisti (Mazzini, Turati, Prampolini) è che “la cooperazione ha una potenza generatrice superiore”. Mancuso, sulle tracce di Kropotkin si dedica a fondare questa dichiarazione su delle solide prove, provenienti per lo più dalla sua amata Nazione delle piante”.
Rivolgendo lo sguardo alla miriade di relazioni che governano i sistemi naturali si trova davvero dappertutto il mutuo appoggio”. È da quand’ero ragazzo che ho appreso la nozione di “simbiosi mutualistica” e grazie a Mancuso ho conosciuto il nome di una straordinaria biologa americana, Lynn Margulis. Da quel che ho letto è a lei che va il merito non solo di aver smontato la teoria della abissale distinzione tra piante e animali, ma anche quello per noi prezioso di aver individuato nel comportamento delle cellule eucariote – le cellule dotate di nucleo – la prova biologica “che noi esseri umani e tutte le creature fatte di cellule nucleate siamo probabilmente dei composti, fusioni di esseri un tempo distinti”. È questa simbiosi originaria il fattore della nostra forza in quanto esseri viventi, piante, animali e uomini.
“Le piante – conclude Mancuso – sono le maestre indiscusse del mutuo appoggio” e le piante rappresentano l’ottanta per cento della vita sulla terra e negli oceani. “Non potendosene andare in giro a cercare ambienti o compagni migliori, una pianta deve per forza imparare a ottenere il massimo dalla convivenza con i suoi vicini”. L’intelligenza naturale delle piante è cooperazione, mutuo sostegno, comunitarismo globale: questa è la forza attraverso la quale la vita prospera. Questa forza che il libro di Mancuso ci aiuta a riconoscere come strumento primo del progresso delle comunità naturali è la stessa che deve animare il socialismo del futuro, un socialismo naturale non più fondato sulla lotta di classe, ma sulla cooperazione globale tra individui solidali, consapevoli delle comuni radici e del comune fondamentale interesse a preservare la vita dell’unica Terra che in tutto l’universo ospita la vita.
P.S.: Mentre scrivevo questo articolo nella bella intervista di Michele Drosi a Claudio Signorile (in questo numero dell’Avanti!) ho lettoparole che mi hanno commosso per la comunanza del sentire e per la sintonia nel momento: “Quello che è morto è il socialismo classista, antagonista, autoreferenziale. Quello che sta crescendo è, invece, un socialismo umanitario, comunitario. E’ la globalizzazione della sopravvivenza e non per il puro profitto. La globalizzazione comunitaria sul piano sanitario, sociale, ambientale. Un mondo nuovo.”