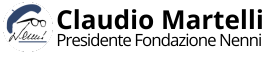Non è questione dei nuovi “cacicchi regionali” – i governatori – come vent’anni fa non lo era di “cacicchi cittadini” – i sindaci. Non è neppure, o non solo, questione di temperamento, di personalità che nulla come un’emergenza – un’emergenza di salute cioè di vita! – può esaltarla; è successo a Conte, è successo a De Luca e a Emiliano, personalità tutte meridionali e tutte diverse.
Il punto vero è un altro ed è che, anche in politica, a differenza di quel che si pensa spesso è proprio l’abito, inteso come il ruolo, che fa il monaco. Soprattutto se si tratta di un ruolo istituzionale e del modo in cui avviene l’investitura o l’elezione. Se, come nel caso italiano, la nomina e l’agire di un capo di governo dipendono da una coalizione parlamentare che in ogni momento può sfiduciarti sarai portato o costretto a ricorrere alle doti di mediazione.
Se invece sei eletto direttamente dal popolo il giorno dopo e per cinque anni puoi assumerti le tue responsabilità, sprigionare il tuo talento e persino il tuo arbitrio, puoi sfidare i tuoi alleati e persino il tuo stesso partito senza rischiare conseguenze immediate semplicemente perché nessuna assemblea può rovesciarti senza dissolvere anche se stessa e provocare nuove elezioni. Ecco un formidabile antidoto all’instabilità e anche ai rinvii dettati dal timore di scontentare questo o quello.
La legge elettorale regionale – più o meno come quella comunale – premia il candidato che coalizza il maggior numero di elettori singoli o di grandi elettori cioé di liste. La legge non prevede limiti alla loro proliferazione e al loro confluire dietro un pastore di greggi che alimenta in ciascuna lista (che siano frantumi di vecchi partiti, clientele o correnti di quelli nuovi) la speranza di ottenere almeno un seggio – domani, chissà, un assessorato o la presidenza di un ente o anche favori più minuti e d’altro genere. Nessun partito può offrire altrettanto perché nessun partito può arrivare al 70 o al 76 per cento dei voti “accozzagliando la qualunque”).
Lo può fare un signore che già dispone del potere istituzionale e sa pescare gli ambiziosi e gli scontenti nelle altrui casate, così disarticolando gli eserciti avversari per reclutarne scampoli a rafforzare il suo primato. Altro che destra, sinistra e centro! La politica è scomparsa da quei territori, congelata o evirata dall’instaurazione di un nuovo potere che resuscita l’arcaismo sottostante all’unità d’Italia. Secoli fa qualcosa di simile avvenne nel passaggio dall’età comunale a quella delle signorie, dei principati, dei ducati, insomma degli staterelli tutti in grado di dividere nessuno di unire la nazione sognata per due secoli da Dante e da Macchiavelli.
Si dirà: l’unità d’Italia non è a rischio e di sicuro non saranno queste Regioni a minarla. Eppure non può sfuggire che già sono uscite dal seminato e poco manca a che le più intraprendenti deraglino. Dovevano essere parlamenti che legificano sulle materie di loro competenza e la sciagurata riforma Bassanini le ha insignite di compiti amministrativi in quasi monopolio – la sanità – e se ne sono assunti molti altri deprimendo i comuni e le agonizzanti province, spogliando la Repubblica e lo Stato dei loro doveri e dei loro diritti in materia di sicurezza, istruzione, ambiente, energia alimentando di continuo contenziosi con lo Stato.
E già De Luca annuncia che su come usare le risorse del Recovery fund europeo la Campania deciderà per se.
Nulla come chiamare “Governatori” i presidenti di Regione rivela la metamorfosi intervenuta, l’alterazione del dettato della Costituzione. Decisiva è stata l’elezione diretta dei vertici regionali da parte del popolo. Competenze crescenti e suffragio popolare hanno instaurato un potere esecutivo regionale che si vuole più legittimato di quello centrale. Schiere di costituzionalisti convertiti al verbo delle piccole riforme hanno perso di vista l’insieme, l’effetto cumulativo prodotto da scelte varie, disgiunte e da sentenze incoerenti: il no al ballottaggio previsto dalla riforma Renzi per decidere chi governerà lo Stato è arrivato dopo il sì ai ballottaggi regionali, il no al taglio del Senato prima del sì al taglio di deputati e senatori. Alle stonature della Corte Costituzionale si è aggiunta una singolare esternazione del Quirinale che nell’incontro – guarda caso – con i presidenti delle Regioni – ha lanciato l’allarme sui rischi di un assalto alla diligenza del Recovery fund da parte delle commissioni parlamentari. I cronisti hanno puntato sul discredito scrivendo di organi parlamentari come di orde fameliche al servizio di lobbies e inconfessabili interessi.
Lo squilibrio di potere tra governo nazionale e governi regionali e il discredito del parlamento non sono gli unici problemi riemersi quest’estate. Nel codazzo dei festeggiamenti per la vittoria dei sì nel referendum costituzionale Grillo ha colto l’occasione per reclamarne ancora una volta il vero scopo: porre fine alla democrazia rappresentativa per instaurare la democrazia diretta. Incurante del plateale corto circuito ha quindi comunicato di voler stare lontano dal caos del suo movimento nel quale proprio la democrazia diretta ha incistato quella babele di volontà e quell’assenza di regole che lo rende incapace di decidere delle proprie cose, quasi sempre incompetente dei problemi comuni, ormai evanescente nei territori di cui aveva guidato la protesta.
Il PD ha vinto le regionali in Toscana grazie a un radicamento storico e a un candidato di solida cultura socialista e liberale, in Puglia e in Campania col protagonismo e il plebiscito listaiolo di De Luca e di Emiliano. In nessuna delle tre regioni in cui ha prevalso il PD era alleato coi 5 Stelle. Viceversa in Liguria, unica regione in cui era riuscito a dar vita a un accordo accettando per candidato governatore un grillino non solo l’alleanza è fallita distaccata di quindici punti dal centro destra di Toti, ma il PD ha perso anche una parte del proprio elettorato. Se a questo aggiungiamo che votando sì al referendum sul taglio dei parlamentari il PD ha reso un pessimo servizio alla democrazia rappresentativa ma ha anche diviso il proprio elettorato contraddicendo ben tre precedenti votazioni in cui aveva detto no penso che al Nazareno avrebbero motivo per riflettere meglio sul già fatto e sul da farsi. A cominciare dal declinare il governo coi 5 Stelle più come stato di necessità che come alleanza strategica. Per il resto saranno le prove cui il governo Conte è chiamato a rispondere a indicare quale senso dare all’alleanza.
Ora urge il piano per investire al meglio le risorse del Recovery fund (ne abbiamo parlato approfonditamente nello scorso numero dell’Avanti!), altrettanto urgente il piano sanitario per utilizzare l’indispensabile MES. La seconda ondata della pandemia ha già investito Francia, Spagna, Regno Unito e altri paesi europei e non è allarmismo pensare che, più o meno a secondo delle misure che metteremo in campo adesso, colpirà anche l’Italia.
Prima dell’auspicato rimbalzo o rimbalzino dell’economia nel 2021 ci sono i mesi che ci aspettano: l’autunno e l’inverno di crisi di tante piccole e medie imprese e di una funesta impennata della disoccupazione dalle imprevedibili conseguenze sociali. Sarà in quel contesto che la prossima primavera torneremo a votare nelle quattro maggiori città italiane: Roma, Milano, Napoli, Torino per non dire Bologna e Trieste. Come si pensa di affrontarle? Zingaretti ha detto un rotondo no alla riproposizione di Virginia Raggi: bene, benissimo purché non sia di viatico al sì a un altro candidato grillino o de Il fatto Quotidiano, come a Genova. Mentre scriviamo il sindaco di Milano, Sala anche dopo aver reso visita a Grillo nella sua casa, non ha ancora deciso se ricandidarsi. A Napoli si dà per scontato che a scegliere il nuovo sindaco sarà il governatore De Luca e anche questa è un’anomalia. Infine a Torino la condanna subita dalla sindaca Appendino stanti le regole grilline le inibirebbe la ricandidatura, ma non c’è nulla di più incerto delle regole grilline.
Dunque, a sette mesi dal voto, anche il futuro delle grandi città sembra appeso a casi e vicende personali, alle ambizioni e financo al narcisismo dei protagonisti, mentre la dimensione e la temperie politica da cui nascono le scelte migliori sono congelate quando non evaporate. Eppure, per limitarsi a questo aspetto, se questa volta, come accadeva un tempo, anziché annettersi tutte le scelte il PD concertasse con gli alleati disponibili le primarie di una coalizione di centro sinistra aprendo un confronto di idee e tra candidati darebbe un grande contributo a arginare l’anti politica e a ristabilire le premesse di un rapporto fiduciario con i cittadini, tra i cittadini, i partiti e le istituzioni, tra se stesso e un più vasto campo di centro sinistra. Non mi illudo che accadrà. La scelta di Zingaretti per un sistema proporzionale con sbarramento al 5 per cento ripete lo schema del sì al referendum taglia parlamentari, contraddice l’originaria vocazione maggioritaria ed equivale nel gioco degli scacchi a un arrocco difensivo teso a preservare un duopolio di potere con i 5 Stelle senza nemmeno essere sfiorati dal dubbio di avvinghiarsi al nulla o al caos.