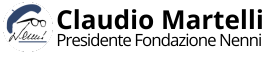Quali riforme devono essere messe in cantiere si sa dagli indirizzi fissati dall’Unione Europea: conversione ecologica e digitale dell’economia, riforme della PA, della giustizia civile, della scuola. Quello che non si sa è come l’Italia le declinerà, con quali strumenti di legge, quali provvedimenti amministrativi, quali procedure di spesa pubblica.
Non sappiamo neppure quante risorse verranno destinate a sussidi e per quanto tempo, quante a investimenti e in quali settori strategici. Tutto è demandato al piano nazionale – “di Ripresa e Resilienza”- che il governo deve presentare a Bruxelles il 15 ottobre.
Le questioni di metodo devono essere assunte a monte della definizione dei contenuti poiché da esse dipende la fattibilità di qualunque piano. Invece non sappiamo quale architettura finanziaria sosterrà un impegno così vasto e gravoso in modo da non precipitare il paese nel baratro di un debito insostenibile.
Non dimentichiamo che ben prima di ricevere i 200 miliardi
che l’Europa ci ha destinato,
per conto nostro ci siamo già
indebitati di altri 100 miliardi
con i quali il totale del nostro
debito è salito a oltre 2500 mld
e, in percentuale, dal 134 a circa
il 160 per cento del PIL.
Sul piano politico non sappiamo
se governo e maggioranza
procederanno da soli o se coinvolgeranno
le regioni, se una
commissione parlamentare ne
accompagnerà l’azione e quale
sarà il ruolo delle forze sociali.
Avremo un parlamento co-governante
che istruirà molti o
alcuni provvedimenti? Si concerterà
con le regioni? Dunque,
tutti insieme, maggioranza
e opposizione, parlamento,
regioni, corpi intermedi concorderanno
la destinazione dei
fondi che l’Europa ci presterà
o ci donerà? Un simile scenario
evoca una forma di unità
nazionale o ne è l’anticamera.
Ma perché ciò accada occorrerebbe
innanzitutto abbassare
il volume dell’ininterrotto, assordante,
intossicante frastuono
che da anni accompagna
ogni dibattito pubblico. Occorrerebbe
un soprassalto di
responsabilità da parte di tutti
o, almeno, dei principali protagonisti
politici a cominciare
dal presidente del Consiglio e
dai leader di maggioranza e di
opposizione. Soprattutto occorrerà
sciogliere preliminarmente
alcune questioni finanziarie
e di governance tuttora
irrisolte: per mettere il sistema
sanitario in sicurezza ricorreremo
o no al MES? A quali imprese
affideremo l’attuazione
della banda ultra larga e la sua
estensione a tutto il territorio
nazionale premesse ineludibili
della transizione digitale?
Useremo i fondi europei come
un bancomat consumandoli in
una pioggia di bonus e sussidi
che andranno a sommarsi a
quelli sciagurati del reddito di
cittadinanza e di quota cento?
I riformisti non negano l’emergenza
e non negano la necessità
di fare debiti per superarla.
Però, a differenza degli irresponsabili
che pullulano non
solo tra i populisti e i nazionalisti
e, come e prima di Mario
Draghi, i riformisti sanno che
i debiti buoni sono quelli fatti
per finanziare riforme lungimiranti
e opere necessarie allo
sviluppo mentre i debiti cattivi
sono quelli fatti per elemosinare
consensi con spese improduttive.
È tempo che questo
antico dibattito torni d’attualità,
che i riformisti ovunque
collocati escano allo scoperto e
si assumano una responsabilità
più grande del tenere in vita un
governo purchessia. Intendo la
responsabilità di parlare a tutto
il paese dicendo come stanno le
cose e quel che bisogna fare.
Viceversa quel che si capisce è
che, almeno fino al 20 settembre,
terranno banco i comizi
nelle sei regioni in cui si voterà,
mentre in tutta Italia andrà in
scena lo scontro sul referendum
taglia parlamentari. Smaltiti i
risultati del referendum e formate
le giunte regionali è facile
prevedere che l’attenzione delle
forze politiche sarà calamitata
dal varo della nuova legge elettorale
e, in caso di vittoria dei sì,
dal ridisegno dei collegi e dall’adozione
degli ineludibili contrappesi
costituzionali all’eliminazione
di 345 parlamentari.
A loro volta, governo nazionale
e governi regionali, Confindustria
e sindacati sembrano più
determinati a scontrarsi sui
livelli – nazionali o aziendali –
di contrattazione che non a incontrarsi
sulla destinazione dei
fondi europei. Insomma, quello
che si annuncia non sembra
lo scenario più propizio alla
concordia nazionale e nemmeno
a un dibattito responsabile
sul nostro futuro.
Anche nella più larga opinione
pubblica prevalgono vecchi
cliché a cominciare dalla recidiva,
pregiudiziale contrapposizione
di Stato e mercato,
agitati come tabù e totem
ideologici, come spauracchi,
come feticci. Ammesso che in
un passato non remoto quella
dicotomia fosse uno spartiacque
veritiero, di sicuro oggi
non lo è più, salvo che nelle
menti obnubilate di politicanti
e commentatori strapaesani e
di sciamani vaneggianti. Nel
mondo reale stato e mercato
sono molto più intrecciati che
contrapposti e la ricchezza e la
forza delle nazioni dipendono
dal grado e dalla qualità della
loro integrazione perché è la
loro integrazione che configura
un “sistema paese”.
Dagli USA alla Cina il capitalismo
è sempre più politico e
la politica, i governi, gli Stati
sono sempre più immedesimati
con il sistema economico capitalistico
e il benessere e la solidità
di una nazione dipendono
dal loro convergere su obbietivi
condivisi. Oggi, il benessere
italiano – come quello tedesco
o francese – dipende in primis
dalle nostre aziende esportatri
ci, dalle loro performances che
colmano o eccedono i disavanzi
accumulati dal lato delle spese
e dei settori deficitari.
Così, mentre fervono dibattiti
antidiluviani tra paladini dello
Stato regolatore e cantori dello
Stato imprenditore, già oggi
e ancor più domani lo Stato è
esso stesso, innanzitutto, capitale.
Dunque, Stato capitalista
nel senso che fornisce alle
imprese in quanto apparati
tecnico produttivi non solo le
garanzie di accesso ai crediti,
ma, non di rado, anche i finanziamenti
diretti, per non dire
gli obiettivi, i progetti e gli strumenti
amministrativi necessari
alla loro attuazione e alla loro
capacità di generare profitti e
ulteriori investimenti.
Ancora una volta tocca ai riformisti
di svegliare dai loro
sonni dogmatici statalisti e
mercatisti, di contenere l’assistenzialismo
nei limiti dell’
indispensabile e di sbarrare la
strada ai disegni delle lobbies
di potere che vogliono profittare
delle emergenze.
L’emergenza sanitaria e ambientale,
economica e sociale
esige un riformismo d’avvenire
che guardi dritto alle cause
strutturali del nostro declino e
le rimuova dal nostro futuro.
Le priorità che sovrastano tutte
le altre impongono di agire con
misure efficaci e immediate per
fermare il declino italiano.
La prima e più importante
riforma è quella di riempire
le culle. Solo accrescendo le
nascite correggeremo l’incombente
drammatico declino demografico
di un paese troppo
vecchio. Non basta. Il centro
di gravità politico, come dice
il piano europeo (Next Generation
UE) deve essere spostato
a favore delle giovani generazioni.
Questo ci impone di
fermare la fuga all’estero dei
giovani italiani più dinamici
e più trascurati – gli espatriati
sono più di mezzo milione
negli ultimi sette anni. I nostri
giovani non sono ingombri da
sussidiare ma risorse da valorizzare,
non sono le vittime
designate ma i soccorritori indispensabili
di una società che
senza di loro si sta spegnendo.
Un esempio tra gli altri. Il
nodo di tanti problemi italiani
– l’inefficienza, l’inefficacia,
l’iniquità delle nostre pubbliche
amministrazioni – potrebbe
essere sciolto formando il
capitale umano costituito dai
giovani nativi digitali perché
i migliori tra loro, assunti per
concorso, modernizzino una
pubblica amministrazione
costituita in maggioranza da
analfabeti digitali ultracinquantacinquenni.
La transizione ecologica – o
verde – è la grande utopia del
nostro tempo. Come altre,
passate utopie, anche quella
ecologica nasce da esperienze,
calcoli, visioni che proiettano
sul futuro, moltiplicandole,
le preoccupazioni di oggi. A
differenza di quelle del passato
però l’utopia ecologica non
vive di attese millenaristiche
e di inverificabili palingenesi,
ma della tensione tra necessità
e riforma, tra l’utopia necessaria
e le riforme possibili.
La sua necessità nasce dalla conoscenza – documentata e prevedibile – dei cambiamenti climatici prodotti dall’incontrollato sfruttamento umano delle risorse naturali e dalla catena di conseguenze che ha comportato e comporta.
Seppur confusamente questa conoscenza induce alla responsabilità e la responsabilità obbliga a intervenire con le riforme possibili del nostro modo di produrre, di abitare, di alimentarci, di comportarci e di vivere.
La pandemia del Covid-19 che in questo 2020 ha già mietuto centinaia di migliaia di vittime ha messo in ginocchio (quale più, quale meno secondo la capacità mostrata dalle diverse leadership e la qualità dei sistemi sociali) l’economia produttiva di gran parte del mondo.
Affermare che la causa originaria risieda nella globalizzazione sembra più che un’inferenza azzardata, una superstizione nutrita di un arcaico, invincibile senso di colpa per la superbia umana che avrebbe osato dominare la natura infrangendo o spostando i confini e i limiti del possibile.
Tutto al contrario, io penso che alla volontà prometeica di usare il fuoco per difenderci, vada attribuita non l’origine del virus ma la capacità dei sistemi sanitari che abbiamo creato di proteggerci, di reagire e di debellarlo quanto prima possibile e persino di imparare a convivere con questo hospes hostis, questo ospite nemico. Chi ne dubitasse dovrebbe rileggere la storia delle passate epidemie – dalle pestilenze del ‘600 alla spagnola del ‘900 – che produssero ben altre ecatombi che dilagarono nell’ignoranza scientifica e nell’impotenza sanitaria.
Ultrapotenti ma sempre inadeguate scienze e tecnologie restano pur sempre le nostre migliori creature e alleate, strumenti e fini del vivere umano e del progresso sociale. Nondimeno non bisogna dimenticare mai che anche le scienze sono figlie delle società che esse orientano e guidano.
Dunque, anch’esse non vanno trattate come oracoli, pizie solitarie che emettono vaticini infallibili. La loro ricerca e la loro azione dev’essere continuamente aggiornata e verificata in un più ampio circuito di conoscenze e di dibattito pubblico, aperto, responsabile e partecipato.
«L’aggravarsi della crisi ambientale è sempre più tangibile, lo documentano i numeri, di giorni di siccità, di metri di scioglimento dei ghiacciai o di millimetri di innalzamento del livello del mare, gli indici di inquinamento atmosferico» (O. Bouin).
La crisi ambientale ci minaccia ben oltre quella sanitaria e non solo per la sua ampiezza incommensurabile, ma per la sua incombente irreversibilità. Oltre la soglia che stiamo lambendo non ci saranno vaccini né farmaci a salvare l’umanità.
Troppi anziani non lo sanno, molti adulti in posizione di responsabilità lo negano o non se ne curano. Non stupisce che a nutrire la speranza e a intraprendere la lotta sia stata un’adolescente. Mai poetica profezia fu più lungimirante di quella di Elsa Morante: « Il mondo sarà salvato dai ragazzini».